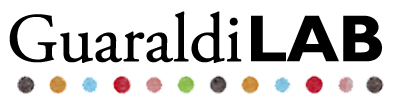La logistica per la consegna in tutto il mondo di centinaia di milioni di dosi vaccinali che debbono viaggiare a meno 70 gradi, con migliaia di camion e container riconvertiti a freezer, ha una logica quasi militare. Non è roba che si fa in un giorno e sono fiumi di denaro. Al contempo, ci viene presentata l’auto elettrica del futuro, quella di Apple, che farà impallidire la Tesla di Musk, a cui viene lasciato però il ruolo di tour operator dello spazio per i nuovi ricchi.
Ricavo queste e altre notizie dal Corriere della Sera che sta sperimentando il nuovo modo di fare giornalismo a pagamento nell’era delle edizioni online fatte su misura, il famoso on demand.
C’è qualcosa di stonato in tutto questo, un’euforia drogata. Per me un segnale. Con il il vaccino alle porte è tempo di smettere il monitoraggio dei livelli di paura che come un seme è stato seminato ad arte in attesa che la classe politica mettesse fine alle turbolenze intestinali in atto, in vista del futuro e definitivo assetto del potere (e della nomina del prossimo presidente della Repubblica, l’Apple Cardopola pandemia). Il fiume di denaro che i nuovi padroni dovranno gestire nel dopo pandemia non servirà certo a pagare i biscotti e le camomille degli anziani decimati nelle case protette dove li avevamo incarcerati, uccisi dall’egoismo di un modello sociale che tollerava a fatica disabili e improduttivi. Ci ha pensato l’invisibile sicario incappucciato di nero e con la falce in mano, come in un film di Bergman.
In questa poco felliniana “Prova d’orchestra” sono in troppi a stonare. Siamo, con oggi, alla trentottesima dose di questi miei poveri Antidoti culturali, senza logistica alle spalle e senza feedback. È ora di smettere, come feci molto tempo fa con i miei articoli su Ariminum, il giornale che avevo visto nascere per le amorose cure del mio amico e autore Manlio Masini. Me lo ritrovo oggi in mano, quel suo giornale, come un segno, in forma di numero monografico dedicato a Fellini, con la firma di due nuovi direttori, Andrea Montemaggi e il bravo, iperattivo e ormai onnipresente Alessandro Giovanardi. Capisco subito che così come ho iniziato questa avventura con Fellini, con Fellini mi toccherà terminarla.
La monografia che ho fra le mani è articolata in 16 capitoli, ben scritti, alcuni per mano di mie vecchie conoscenze, come Italo Cucci e Italo Minguzzi, poi persi di vista nel dilagare della vita perché impegnati in battaglie e su campi da calcio diversi da quelli che ho praticato io. Una generazione comunque di vecchi riminesi doc che ricompare sulla scena del delitto “felliniano”, richiamata dal Master Chef per cucinare un bel panettoncino di Natale, ben farcito, con gustosi canditi inevitabilmente autoreferenziali; ben incartato nell’arguta critica sui rischi del museo/mausoleo che lo stesso chef stellato riconduce al «vespasiano per i piccioni» aborrito da Fellini. Ma temo sia un dolce avvelenato.
Non vi troverete traccia del ritorno trionfale di Fellini al Grand Hotel voluto da Marco Arpesella nel 1983, dopo anni di “bidoni” tirati dal maestro al paesello natio: quell’omaggio straordinario della città al suo figlio transfuga e bugiardo, con la tv di Stato al completo capitanata da Sergio Zavoli sembra non essere mai esistito. Non c’è traccia della storia (dolorosa) della casina sul porto e del lungo oblio successivo di Fellini che ho avuto il torto di denunciare per un ventennio fino alla nausea; fino a quando l’oggettiva (ma un po’ cinica) bravura del sindaco Gnassi e i milioni del ministro Franceschini non hanno avuto bisogno del colpo di fulmine felliniano per condensarsi improvvisamente dalle nuvole della politica romana e piovere abbondantemente sulla nostra città. Non c’è traccia del cinema Fulgor rinato come bordello parigino più che come amarcord di Amarcord (film non amato dai riminesi). Scomparso anche dalla programmazione della “vernice ”. Scomparso anche Umberto Eco seduto vicino a me e ad Arpesella nel giardino al momento dell’apparizione grandiosa del Grand Rex (che nel souvenir di Cavriani sopravvive solo come fotogramma fuori contesto). E neppure la primigenia e poderosa rivisitazione de La mia Rimini predisposta per il Festival di Cannes sembra mai esistita in questa misteriosa storia del rapporto di Fellini con la sua città. E pur parlando abbondantemente del Libro dei sogni, non c’è traccia della sua versione digitale e trilingue curata da Paolo Fabbri e dal sottoscritto in tre lunghissimi anni di lavoro con Piero Meldini e tanti altri: svaniti nel nulla.
Si chiama damnatio memoriae. E qualunque sia la ragione – o la causa –di questo modo di concepire l’informazione, sappiano gli amici di Ariminum che non ha mai portato a buoni risultati. Nel suo Inferno immaginario preconizzato dal bravo e davvero compianto Dario Zanelli (Edizioni Guaraldi) il povero Fellini dovrà vederne ancora delle belle.