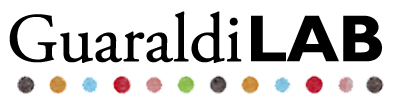In questo autunno ormai avanzato, coi suoi colori e le sue languidezze culinarie favorite dal prudente restarsene a casa, io e mia moglie andiamo pazzi per un insaccato fuori moda chiamato coppa di testa (ma anche soprassata, capofreddo o capaccia, in Toscana o suppizzata in Calabria, con l’aggiunta di peperoncino). Proprio perché fuori moda e poco richiesta, il mio amico Luigino Tiraferri, universalmente noto per le sue salsicce, me ne ha regalata una intera, forse un po’ troppo grassa rispetto a quelle toscane che prediligo, ma pur sempre notevole. Per chi non lo sapesse la coppa di testa si fa con tutti i residui del disosso del suino, dopo aver riservato la carne nobile per salsicce, salami e cotechini, oltre ovviamente al prosciutto con tutte le varianti di culatelli e culacce varie. Ma gli ingredienti principali, da cui il nome, vengono dalla testa del maiale, beninteso senza il cervello: le grasse cartilagini delle orecchie e del grufolo, le guance, tutti i muscoletti della mascella e i ritagli della cotenna del collo. Non è infrequente che ci scappi anche qualche ossicino, lo sentite bene quando si taglia all’affettatrice. Vengono esclusi gli occhi, di solito, ma solo perché gli occhietti da suino fanno un po’ impressione sezionati, se no sarebbero ottimi, come tutto il resto. Dopo la bollitura del tutto in un paiolone di rame assieme ad aromi vari secondo l’estro del norcino, da un insieme di apparenti schifezze, dopo essersi raffreddata, grazie al collagene di cui la materia prima è ricca, la coppa diventa oltre che squisita, persino esteticamente bella: elastica e gelatinosa, coi colori dell’autunno. Davvero del porco non si butta niente.
Questa coppa di testa mi fa pensare agli Usa. Se non rischiassi di apparire irrispettoso, direi che i cinquanta Stati che compongono gli Stati Uniti d’America, pressati uno sull’altro, anche visivamente con i colori rosso e blu dei due schieramenti, sembrano davvero come gli ingredienti di cui sopra, una sopressata di cotenne e cartilagini gelatinose di un Paese che nel suo insieme, ben cotto e insaccato, emana ancora un suo inconfondibile profumo di democrazia, alla faccia delle singole schifezze. Ma che improvvisamente, nel recente processo di cottura che chiamiamo “elezione presidenziale”, sembra denunciare che qualcosa è andato storto. Dal paiolo di rame del Nord America comincia e emanare un lezzo che non mi piace. Avete sentito anche voi la dichiarazione del norcino Mike Pompeo di origini abruzzesi? «La transizione ci sarà… verso un secondo mandato a Trump». E che il presidente in carica continui a rifiutare la vittoria di Biden non vi preoccupa? In questi Stati Disuniti d’America, zeppi di nostalgie e di reminiscenze italiane, dove sarebbe interessante andare a vedere nel dettaglio come ha votato la Palermo di California, la Roma del Texas, le due Firenze del South Carolina e dell’Arizona, le tre Venezia della Florida, di Los Angeles e di New York, la Milano della Georgia o la Mondovì del Wisconsin; oltre naturalmente alle due Rimini che già ben conosciamo per averne parlato in questa sede, scorre in misura abbondante sangue italiano. Ciò significa che dove una volta c’era solo la classica doppietta da caccia dei bisnonni emigrati (che al massimo ammazzava un paio di storni alla volta), oggi ci sono rastrelliere piene di mitragliatori M60 calibro 7,62. E non solo nelle case di origine italiana. Ho scritto a un amico italiano che vive da vent’anni a Seattle: non hai paura che gli Usa piombino in una guerra civile? Mi risponde l’amico che conosce bene l’America: «Guerra civile, no. Ma ci saranno seri disordini se Trump non molla. Vedremo come le istituzioni e i check and balance riescono a fare il loro mestiere». Il check and balance è un concetto astratto sancito dalla lontanissima Costituzione americana del 1787 che indica banalmente la necessità che i tre poteri dello Stato – legislativo, esecutivo e giudiziario – si bilancino, controllandosi reciprocamente. Da noi, uguale. Il che vuol dire tutto e niente, se non addirittura la possibilità di un conflitto istituzionalizzato, come si
sta profilando.
E a furia di conferme di vittorie Stato dopo Stato per Joe Biden e ormai una maggioranza schiacciante alla Camera, noi poveri europei capiamo solo che lo scenario politico americano resta quello di una polveriera e che un Trump impazzito farà di tutto per fomentare disordini e convincere la gente che solo lui è garante di law and order. Ma se anche Trump si decidesse a mollare, basterà la buona volontà del vincitore a “unificare” l’America? «Alla fine – mi scrive l’amico americano – prevarrà il senso patriottico. L’America è sempre stato un Paese diviso. Il clown bugiardo ne ha tirato fuori il peggio».
Sì, forse una speranza c’è. Che i parenti degli emigrati italiani che hanno votato «il clown bugiardo» spediscano urgentemente ai loro congiunti container pieni di frisse piemontesi, cotechini con lenticchie, finocchiona, soppressata, ‘ndujia, culatelli e, a voler strafare, salama da sugo! Per ricordare a loro e a noi stessi quale e quanta cultura abbiamo forse dimenticato in cambio di quell’orrido hamburger con cipolla e ketchup che ha invaso persino l’Europa e che i nostri figli hanno finito per prediligere. Rimpariamo dai nostri comuni antenati la lezione che del porco non si butta via niente. Basta smontarlo e cucinarlo a dovere.