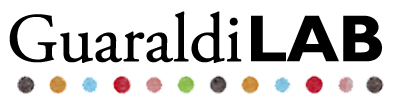Vorrei potervi parlare dei primi bolliti misti di stagione, con scaletta, coda e lingua e quadrucci in brodo; di sugoli di uva fragola, di gelatina di mele cotogne, di marroni arrostiti nel padellone bucherellato sul fuoco della grande rola (il camino che fungeva da cucina e da riscaldamento centrale). Non di Covid, di tamponi, di terapie intensive, di morti ultrasettantenni «inutili», non ne posso più. Me l’ero ripromesso, giuro. Invece no, ancora una volta dovrò parlarvi dei morti che ci propone, con feroce ironia, questo mancato ponte dei morti, questa anticipata “estate di San Martino”: dall’indimenticabile Sean Connery del Nome della rosa e degli Intoccabili (più che di James Bond), al grande, grandissimo Gigi Proietti di «nu’me romp’ er ca…», fino al piccolo parroco di Riccione, don Giorgio, degno figlio di don Oreste.
Ma se proprio debbo farlo, mi perdonerete se preferisco parlarvi della lontana storia d’amore di uno che certamente non conoscete, morto anche lui pochi giorni fa alla veneranda età di 101 anni, cedendo non al virus ma alla regola aurea che a un certo punto della vita si muore…
Questo morto era uno che conoscevo abbastanza bene, si chiamava Fabrizio Dentice D’Accadia, un nome dimenticato persino da chi continua a fare il suo stesso mestiere, quello del giornalista. Già, perché era semplicemente un giornalista, assunto nella redazione dell’Espresso di De Benedetti e Scalfari quasi dalla fondazione del settimanale formato lenzuolo, assieme a Pasolini, Giachetti, Saviane, Eco, Zevi, Calamandrei, Arbasino, Cederna e calibri di questo genere. Il solo epitaffio funebre che ho trovato su di lui nei media è stato quello di aver firmato, nel lontano 3 marzo 1968, un celebre servizio che consacrò la rivoluzionaria esperienza psichiatrica di Basaglia.
Aveva fatto il giornalista per sbaglio, Fabrizio Dentice. Era pigro e poco motivato, si definiva anzi un inetto. «Inetto è una parola che mi piace – dichiarò forse nell’unica intervista rilasciata già da vecchio –, mina il culto dell’efficienza. La disperazione montava quando mi mandavano a intervistare qualche personalità. Non sapevo che cosa domandare. Avrei parlato volentieri del tempo, delle donne, dei luoghi, ma di fronte a questioni specifiche mi bloccavo. Un incubo. Ho odiato il mio lavoro». Un autoritratto impietoso e forse ingiusto. L’intervistato in questione si chiamava Mitterand.
Lasciato L’Espresso si ritrovò a Panorama – «settimanale voluto dagli americani», annota! – sotto la direzione di Leo Lionni, geniale designer e forse suo unico grande amico di una vita. A dispetto della sua mancanza di passione per il giornalismo, si ritrovò a fare il caporedattore centrale di Panorama, come un cane da caccia (sua grande passione) messo alla catena. Alla direzione invece, si succedevano, uno dietro l’altro, cani ringhiosi e feroci.
A un certo punto si innamora perdutamente di Maria Livia Serini e qui inizia la sua vera storia. Erano sposati entrambi, fuggirono in Spagna e fecero perdere le loro tracce. «Il giorno della separazione – confessava Dentice – il marito di Maria Livia tentò di strangolarmi in ascensore»; in realtà gli andò bene perché poi sposò una ereditiera e visse nel lusso il resto dei suoi anni. Già, ma chi era dunque tanto oggetto del contendere? Impossibile rispondere. Maria Livia era la cultura fatta informazione. Bazzicava tutti gli autori e gli editori che contavano, scandiva i tempi delle cose da sapere e da leggere, aveva un fiuto pazzesco per scovare i talenti, teneva una rubrichina all’Espresso che era una specie di carta moschicida per i giovani intellettuali in libera uscita come me. Una donna straordinaria.
Fabrizio e Maria Livia abitavano in via San Simpliciano 2, a pochi passi dalla mia casa milanese di via Fieno. Fu una stagione di incontri fuori del comune. Da loro erano di casa anche Roberto Cerati – mitico e potentissimo direttore commerciale di Einaudi – e la sua irrequieta e bellissima moglie Carla. Gli uffici stampa di tutte le case editrici italiane e straniere facevano la coda per essere ammessi. C’erano persino Roberto Vecchioni e Gigliola Cinquetti. Eppure, misteriosamente, quella stagione non ha lasciato tracce in Internet: di Fabrizio Dentice poche righe, di Maria Livia Serini assolutamente niente. Come non fosse mai esistita. Eppure, la testimonianza d’amore di Dentice per la sua Fata Turchina vale molto di più di una pagina in Wikipedia, più di una mega celebrazione istituzionale: «Fu nell’estate del 1981 che Maria Livia morì per un tumore; e scoprii quello che non avevo mai provato in vita mia, la forza devastante del dolore».
Da quella forza (e forse dall’influenza di Lionni) nacque la favola surreale di Egnocus e gli Efferati che racconta quella piccola-grande storia d’amore e di morte esattamente come Federico Fellini fa con la sua fatina Giulietta nel Libro dei sogni.
Infine, la lapidaria testimonianza su di sé, disperso fra i dispersi come Fellini: «Oggi basta un attimo per diventare un dinosauro, scaduto come uno yogurt. Il futuro ci riguarda sempre meno. Il passato, il passato boh». Un capolavoro giornalistico.