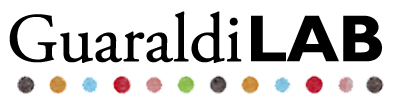Non è mia intenzione fare lo storico della domenica e neppure il politicante del martedì; non è il mio mestiere e ce n’è già abbastanza in giro. Ma una piccola lezione di storia deve essersi infilata come una spina nel mio cervello e nel mio cuore mentre assisto sgomento a quanto succede negli Usa e ora pulsa a ogni nuova notizia che leggo, minacciando di fare infezione.
Abilmente preparata dall’orrendo periodo ricordato come “strategia della tensione”, culminata nel brevissimo governo filo-fascista di Tambroni, l’Italia fu davvero sull’orlo della guerra civile come ci racconta un bel libro di Franzinelli e Giacone appena uscito in libreria. Ma subito dopo, nei primissimi anni 60, in un mutato contesto internazionale che induceva all’ottimismo se non addirittura all’entusiasmo, con le grandi figure carismatiche di Kennedy, Krusciov e papa Giovanni XXIII, il nostro Paese sembrava aver imboccato decisamente la strada della democrazia.
Poi, un maledetto venerdì di novembre del 1963, esattamente il giorno 22 alle 13.30 ora locale del Texas, 57 anni fa, lo scenario muta improvvisamente a Dallas con l’assassinio di Robert Kennedy. Ci sono delle date – e delle immagini – che marcano la psiche delle persone; e quella di Jacqueline Kennedy che si getta sul corpo del marito colpito a morte è per me una di queste. Tutti noi che vedemmo quelle immagini dai primi televisori in bianco e nero sapevamo bene che l’America scandiva il ritmo della storia e del costume a tutti i livelli, nel bene e nel male, con almeno 15 anni di anticipo rispetto all’Europa. E si sarebbe dunque dovuto attendere il 9 maggio 1978 per sancire che anche da noi un assassinio politico, quello di Aldo Moro, avrebbe potuto cambiare la storia del nostro Paese.
Poi, stranamente, è come se i flussi di influenza fra Italia e Usa cambino direzione. E la storia di un piccolo miliardario locale che riesce ad andare al potere e a restarvi fino al novembre 2006, quando viene scalzato da Prodi per un pugno di voti, rimanda inevitabilmente alle recenti votazioni americane e al dramma di due Paesi culturalmente e politicamente spaccati a metà. Ma la vicenda di un miliardario megalomane a capo della massima potenza mondiale che, come il suo piccolo omologo nostrano, non vorrebbe ora rinunciare al potere è qualcosa che va ben oltre la cronaca e ferisce a morte la stessa idea di democrazia rappresentativa. Perché a dispetto di tutto e di tutti, anche i più trinariciuti fra i comunisti italiani avevano sempre guardato all’America come a un faro di civiltà. E vederla oggi imbarbarita e quasi sull’orlo di una guerra civile – come noi nel 1960 – mette letteralmente i brividi. Anche perché Trump non è Tambroni e gli Usa sono una sommatoria tutt’altro che omogenea di ben 50 Stati distinti, anche se federati, che in totale sommano a quasi 330 milioni di abitanti, metà dei quali la pensano esattamente come The Donald. Mi fermo qui perché mi sento male al solo pensiero che se si tornasse domani a votare in Italia ci troveremmo in una situazione non dissimile in cui metà degli elettori la pensano come Salvini e hanno fatto il tifo per Trump.
Quando nel lontano1942 Cesare Pavese riuscì finalmente a pubblicare con il conte Valentino Bompiani la leggendaria antologia intitolata Americana, a cura di Elio Vittorini, si era in piena guerra mondiale, con gli Stati Uniti nemici, tra censure fasciste, tagli redazionali e svariate peripezie: ma per la cultura italiana che per la prima volta poteva leggere narratori come Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Sherwood Anderson, Erskine Caldwell, oltre ai classici Poe, Melville, Hawthorne, Twain, Jack London, Henry James, Dreiser, fu uno shock epocale. Che grande Paese era mai quello che poteva generare autori così straordinari! Lo capì bene il ministro fascista di quegli anni, Pavolini, che il 7 gennaio 1941 aveva bloccato la pubblicazione perché «l’uscita – disse – in questo momento dell’antologia Americana non è opportuna. Gli Stati Uniti sono potenzialmente nostri nemici; il loro presidente ha tenuto contro il popolo italiano il noto atteggiamento. Non è il momento per usare cortesie all’America, nemmeno letterarie». Ineccepibile.
Oggi quella stessa America che faceva così paura al regime fascista per la cultura che esprimeva, sembra invece generare solo mostri come il QAnon, la folle teoria complottista di estrema destra cui Trump ha strizzato l’occhio per tutta la campagna elettorale. L’eroe americano del «make America great again» non assomiglia neppure lontanamente al Grande Gatsby, ha solo l’aspetto flaccido di un pazzoide che non vuol perdere il potere e il ventre gonfio di birra e hamburger dei suoi 165 milioni di elettori. Inquietante. Sembra di essere tornati nel Texas degli stermini delle tribù indigene autoctone, nella Dallas dell’assassinio di Kennedy.
E diciamola tutta: questa democrazia quasi dinastica che ha spesso gestito la politica di quel grande Paese come fosse un affare di famiglia, dai Bush ai Trump, appunto, non è più una garanzia per nessuno. Questo spaventa, ma è una sfida da raccogliere. Nel nome di Vittorini.