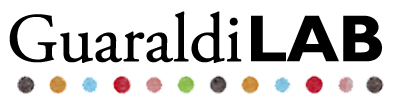Riascoltando Il testamento di De André riprendo in mano, quasi rabdomanticamente, quello che ritengo il più bello fra tutti i libri del mio amico Piero Meldini, La falce dell’ultimo quarto, un testo ormai dimenticato, del 2004, edito da Mondadori, badate bene, non da Adelphi, la casa editrice che lo lanciò nel gotha letterario.
Piero è stato mio braccio destro e sinistro, mio occhio e mi orecchio nella conduzione della casa editrice che avrebbe potuto portare anche il suo nome accanto al mio, tanto eravamo in simbiosi.
Fin dai suoi esordi come autore di narrativa ho sempre pensato, mai dichiarandoglielo, che il Meldini saggista fosse di gran lunga migliore del Meldini narratore. E non perché i suoi romanzi non mi piacessero, sia chiaro, ma perché mi sembrava che la scelta della narrazione fantastica, dopo tanti anni di saggistico e rigoroso articolarsi del suo pensiero, di cui aveva dato grandi prove sia in ambito storico che psicoanalitico, fosse in qualche modo l’equivalente di un sintomo nevrotico, l’emergere di un
desiderio troppo a lungo represso e disconosciuto, il bisogno di sperimentare il coté irrazionale e materno della sua creatività: quello narrativo, appunto, auto-concependo e sentendo generarsi in lui personaggi e storie, figure e situazioni in qualche modo autonome, altro da sé, figli, appunto.
Forse la mia è una tesi azzardata, Piero me l’ha già cassata senza scampo in privato, ma continua a sembrarmi che La falce dell’ultimo quarto, il libro del suo “tradimento editoriale” di Adelphi, concepito nell’opulenza (all’epoca) dell’alcova mondadoriana, sia proprio il testamento di uno scrittore deluso dai suoi figli legittimi, quelli nati dall’innamoramento di Roberto Calasso, mitico editore/autore di Adelphi, per il piccolo e geniale bibliotecario riminese.
Notate bene che la fama di Meldini era già ampiamente circolata per le sue straordinarie antologie storiche, segnatamente Reazionaria. Antologia della cultura di destra in Italia, che viene periodicamente riscoperta e consultata come un oracolo dei tempi in cui parlare di «cultura di destra» era una bestemmia, mentre oggi bisognerebbe farla studiare a memoria a Salvini, Meloni e La Russa.
Con quel “tradimento editoriale” – e soprattutto con quel contenuto – Meldini sembrava voler dichiarare di non credere più nell’eternità immanente della fama che deriva dal lascito del proprio dna letterario. La trama del libro è ben più che un indizio in questo senso: in una Rimini pre-gnassica puntigliosamente descritta (mirabile la gita alle Grazie: una foto d’epoca), il mercante di granaglie Bartolomeo Bartolini è annichilito dal non sapersi decidere a chi lasciare la propria eredità, se a un non affidabile nipote o al figlio sognatore melanconico e incapace. Né l’uno né l’altro si piegano al suo bisogno di sopravvivere nelle cose che vorrebbe lasciar loro; e la storia finisce male. L’ossessiva scrittura e riscrittura del Testamento a ogni colpo di scena (che naturalmente non va spiattellato) è lo straordinario espediente letterario che Meldini adotta per raccontare quel disagio.
Ora, è un fatto che tutti e tre i primi romanzi di Meldini firmati Adelphi fossero una straordinaria trilogia sulla morte, antidoti della malinconia, esorcismi letterari compiuti sotto il chiarore magico della Luna. Mentre la falce incombente (per via dell’età) dell’ultimo quarto, con le sue nebbie felliniane che tutto dissolvono e inghiottono, sembra far trasparire le ragioni vere della “fuga amorosa” dell’autore su altre sponde editoriali.
Attenti alle banali spiegazioni di un primo amore ingrigito dal normale tran-tran editoriale che deve scovare di stagione in stagione sempre nuovi talenti da passare nel tritacarne letterario dei premi e delle vendite: sarebbe solo una mezza verità. Piero nega, ma io ricordo bene che Calasso in persona gridò al miracolo laico salutando ne L’Avvocata delle vertigini l’ultimo grande romanzo gnostico della letteratura
italiana. Notate che Meldini era davvero culturalmente e letterariamente molte spanne più in su dei suoi colleghi narratori di quegli anni; e quello era il suo primo romanzo!
Co s’è dunque, e a chi vorrebbe lasciarla Meldini questa sua benedetta eredità? Temo che per l’ex responsabile della più brillante collana di psicoanalisi del dopoguerra la risposta sia fin troppo scontata: assomiglia terribilmente alla nostra vita, alle cose che abbiamo fatto e nelle quali abbiamo forse inutilmente investito.
Ma viviamo in tempi in cui sembra che né figli né nipoti siano interessati a riceverlo, questo lascito. Non figli veri e neppure figli letterari. E neppure la città in quanto tale saprà beneficiarne, anch’essa come inghiottita dalla tempesta in cui precipita il felliniano aereo di Mastorna destinato a restare solo come una sinistra carcassa sulla piazza dove è precipitato, animata ormai solo da fantasmi, a ricordarci che nessuno si salva da solo e che – conclude De André – «quando si muore si muore soli».
Sono personalmente sicuro, sicurissimo, che Piero ha riscritto per l’ennesima volta, in questi anni lunghi di silenzio, il suo Testamento: ovviamente in forma di romanzo. E sono curioso, curiosissimo di leggerlo.